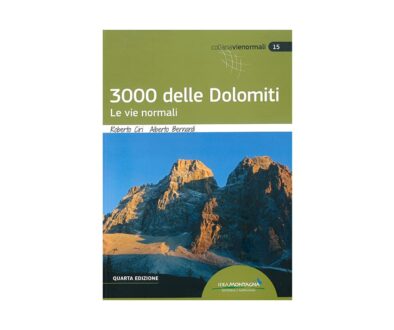TORRE DELLE MADRI DEI CAMOSCI – JOF FUART
Torre delle Madri dei Camosci – Jôf Fuârt
Via Deye – Peters
640 m V+/A0 (VII+)
Ripetizone: M. Dall’Argine – E. Dreolin, 07/08/2020
Il pomeriggio di Giovedì 6 agosto 2020 io ed Euge saliamo con gli zaini carichi dalla val Saisera verso lo Jôf Fuârt: il nostro obiettivo per l’indomani è lo sperone nord-est della Torre Madri dei Camosci, via Deye-Peters.
La via, una classica delle Alpi Giulie dalla fama addirittura internazionale, non presenta in sé delle grosse difficoltà tecniche.
La massima difficoltà d’arrampicata si affronta su un brevissimo tiro di corda superato in “A0” sia dagli storici apritori che da quasi tutti i ripetitori. Il “problema” della via risiede nelle condizioni, spesso proibitive, che caratterizzano il primo effettivo tiro di corda, l’accesso alla via e la discesa lungo cengia degli dèi e gola nord est.
Si sarebbe rivelata una scalata di grande valore sia estetico che culturale: uno spaccato della storia dell’alpinismo giuliano.
Avvicinandoci, ecco la torre: si erge imponente tra le cime Riofreddo e Fuârt. Assieme, queste tre aspre sorelle disegnano nel cielo l’inconfondibile profilo montuoso simbolo della conca del rifugio Luigi Pellarini. Qui abbiamo passato una breve ma bellissima serata in compagnia di alcuni studenti triestini, le simpatiche rifugiste (una delle quali conosceva Euge) ed il “capo” Giorgio Da Rin. Questi, prima di coricarsi, si è seduto di tavolo in tavolo informandosi premurosamente su quali fossero i programmi per l’indomani di ciascun ospite del rifugio: un comportamento che ricordo con nostalgia se penso al “rifugismo” meno intimo tipico delle zone frequentatissime.
La mattina molto presto cominciamo a salire verso le cime solo apparentemente vicine. Mentre camminiamo penso a come dev’essere stato per gli apritori seguire per la prima volta questa linea. Avevo letto che prima di giungere al tiro chiave in strapiombo, Adolf Deye e Rudolf Peters avevano scalato il celebre gran diedro praticamente senza utilizzare chiodi. Com’è possibile, con i mezzi dell’epoca (1929) riuscire in una prestazione del genere? Purtroppo (e non credo per fortuna) erano figli di tempi duri, temprati forzatamente dalla passata grande guerra e da scomodità che la mia generazione non ha mai conosciuto.
Giunti alla base dello zoccolo che difende il gran diedro si palesa subito la prima difficoltà: un “crepaccio” molto profondo separa il nevaio basale dalla parete scalabile. E’ vero che si potrebbero evitare i due tiri della via Angelina che portano al soprastante gran diedro seguendo la via originale, ma quest’ultima ci è stata più volte sconsigliata (una sezione della cengia soprastante il grande zoccolo è franata rendendo terrosi, umidi ed ancora più esposti passaggi delicati).
Discutendo sul da farsi notiamo un cordone penzolare sulla verticale dell’unico punto dove la neve si appoggia saldamente alla parete.
Parte a sorte Euge. Scala un tiro lungo ed aereo che porta ad una cengia mediana. Il tiro successivo porta direttamente alla base della bagnatissima placca nera che difende il gran diedro.
Nel recuperare Euge sono preso dallo sconforto: sapevo che il primo tiro fosse bagnato ma non avrei mai immaginato a tal punto! L’acqua gocciola copiosamente e la roccia ha un aspetto viscido e muschioso. Scorgo alcuni cordoni fradici. Fosse toccato a me il tiro avrei piantato sicuramente qualche chiodo per venirne fuori. Euge non ha praticamente avuto problemi. Un V+ bagnatissimo superato con grande dignità ed eleganza. Appena supera lo strapiombo soprastante intuisco che stia sostando finalmente alla base del gran diedro.
A questo punto la musica è un’altra: tiri su tiri di arrampicata elegante, esposta, su una roccia di qualità eccelsa. Scalo e per un momento mi sento spaesato: “ma questa è la roccia delle dolomiti!” urlo a Euge. Dimentico che siamo in Giulie ed in effetti scopro che la roccia che stiamo stringendo è dolomia.
Usciti dal diedro godiamo di un paesaggio grandioso in tutte le direzioni: comincia la seconda parte della salita lungo l’arrotondato spigolo. Raggiungiamo presto il breve strapiombo chiave e tocca a me. Bramo liberare il tiro e sono carico. Ci prendiamo il nostro tempo, mangio un po’ di nocciole, bevo un po’ d’acqua, mi libero di un po’ di peso e via!
I primi atletici movimenti li sento nelle mie corde ma poi cominciano gli svasi. Ce la metto tutta, stringo i denti… ma niente.
Uso un cordino penzolante per raggiungere una buona presa e da qui continuo a provare la libera dove possibile fino alla sosta.
Euge, giustamente, non ci prova nemmeno appesantito com’è dal materiale. Tocca a lui l’ultima difficoltà: un muro verticale di difficoltà sostenuta, forse il tiro più bello.
Giungiamo, dopo aver percorso lungamente lo spigolo, all’ultima sosta su masso e con le corde in spalla cominciamo a salire slegati verso l’alto per secondi e terzi gradi. Scorgiamo forse prima del previsto un ometto sulla destra che ci porta all’evidente cengia degli dèi.
La discesa vera e propria comincia qui e non è decisamente da sottovalutare. Tra i numerosi passaggi esposti, quello che ci ha dato più da pensare è un’interruzione della cengia che obbliga ad un’eventuale spaccata o breve salto. Noi abbiamo optato per superare il “buco” assecondando cautamente la cengia e muovendoci evitando salti potenzialmente poco accurati.
La discesa lungo la gola NE è anch’essa impegnativa ma agevolata da staffe e pezzi attrezzati. Alla base della gola notiamo che i problemi non sono ancora finiti: un’altra crepacciata tra margine del nevaio basale e la cengia sulla quale siamo. Proviamo a scendere disarrampicando nel crepaccio, ma notiamo che proseguire lungo quell’intaglio non dà possibilità di risalita più avanti.
Risaliamo sulla cengia e prima ancora di optare per una breve doppia su chiodi noto un vecchio golfaro spuntare dalla roccia: avremmo usato quello. Ci caliamo fino al margine del nevaio e piedi contro la roccia ci diamo una spinta per finire proprio sulla superficie della colata di neve dura.
Recuperiamo le corde molto instabilmente ancorandoci ad una improvvisatissima longe fatta di cordino e martello col retro piantato nella neve. Disarrampicare il nevaio senza ramponi e picozza sarebbe stato troppo pericoloso così decidiamo di traversare orizzontalmente usando il retro del martello come fosse la becca di una picozza.
Raggiungiamo le ghiaie e via di surf fino al Pellarini. Potrei raccontare delle vesciche, delle innumerevoli volte che a questo punto ci siamo trovati fuori sentiero in mezzo ai mughi, di quanto Euge odiasse il cuscus che ho preparato e degli innumerevoli episodi di meteorismo… ma questa è un’altra storia.
Mauro Dall’Argine