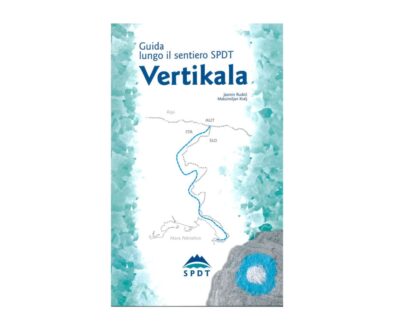IL RISCALDAMENTO GLOBALE E LA MONTAGNA
“Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno… ma quello che accadrà in tutti gli altri giorni che verranno può dipendere da quello che farai oggi. È stato così tante volte.”
È con questo richiamo alle responsabilità, tratto dal celebre romanzo di Ernest Hemingway “Per chi suona la campana”, che il prof. Maurizio Fermeglia chiude l’incontro serale organizzato il 16 marzo, in modalità digitale, dalla Scuola di Sci Alpinismo Città di Trieste e dalle Scuole di Alpinismo Emilio Comici ed Enzo Cozzolino per gli istruttori e per gli allievi dei corsi.
Maurizio Fermeglia, ex Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, alpinista, accademico del CAI, Istruttore di alpinismo e sci alpinismo, membro del Soccorso Alpino, per molti anni è stato istruttore della Scuola di Sci Alpinismo, all’interno della quale ha dato forte impulso all’attività didattica e alla sicurezza.
Questa iniziativa, partita proprio da Trieste a seguito dell’intervento dello stesso prof. Fermeglia al 38° Congresso delle Scuole del CAI tenutosi alla Sissa nel 2019, è un primo passo verso l’introduzione strutturale del tema dei cambiamenti climatici all’interno della didattica del CAI. Il progetto, infatti, oltre all’organizzazione di incontri dedicati con gli allievi, si propone di formare dei “tutor” che si faranno carico della divulgazione nel contesto delle Scuole.
Nonostante l’orario serale, l’incontro è durato quasi tre ore, con insegnamenti ed evidenze che hanno smosso preoccupazioni, seguite da altrettante domande.
Sono anni che gli scienziati ripetono lo stesso avvertimento, e che restano inascoltati. Nel 2009 John Beddington, consulente scientifico del governo inglese, aveva ipotizzato per il 2030 la “tempesta perfetta degli eventi globali”. Aumento della popolazione a 8,3 miliardi, aumento della richiesta di cibo del 50%, aumento della richiesta di energia del 60%, aumento della richiesta di acqua potabile del 30%. La deforestazione, lo sfruttamento del suolo, l’utilizzo di combustibili fossili causano l’aumento delle emissioni di CO2 che provocano il riscaldamento globale e i relativi cambiamenti climatici. Questi innescheranno, a loro volta, altri avvenimenti a catena: eventi metereologici estremi, perdita di biodiversità, instabilità geopolitica, migrazioni, crisi sociali ed economiche, attacchi alle infrastrutture informatiche. Ancora prima, nel 1986, il Nobel per la chimica Richard Smalley aveva individuato 10 rischi globali, mettendo la scarsità di acqua, di cibo, di energia e la tutela dall’ambiente tra i primi quattro.
Oggi sembrano essersene convinti anche gli economisti. La crisi climatica è in atto. Nel 2019, al World Economic Forum di Davos, in Svizzera – dove si riuniscono annualmente attori economici e politici della scena internazionale – viene presentata la mappa dei rischi globali. Tra essi, i rischi ambientali. Nel 2021 il Global Risk Report viene aggiornato, inquadrando i rischi ambientali come quelli più probabili e impattanti per il pianeta.
È arrivato il momento di persuadere la politica. L’UE è stata in prima linea negli sforzi internazionali per lottare contro i cambiamenti climatici ed e stata determinante per l’intermediazione dell’Accordo di Parigi. Si tratta del primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, adottato alla conferenza di Parigi sul clima (COP21) nel dicembre 2015, a cui hanno aderito finora 197 Paesi. Purtroppo però questo percorso non è lineare: pensiamo, ad esempio, alla temporanea uscita dall’accordo da parte degli Stai Uniti durante l’era Trump, o alla marcia indietro del Brasile di Bolsonaro. Il primo è il secondo emittente globale di gas serra, l’altro ospita ben il 60% della Foresta Amazzonica, principale polmone del mondo e continuo oggetto di deforestazione. Anche la disinformazione ed il negazionismo hanno preso piede – c’è chi sostiene infatti che il riscaldamento globale sia “fisiologico” e non opera dell’uomo. In questo contesto però, ci sono anche segnali positivi all’orizzonte: gli Stati Uniti sono rientrati negli accordi di Parigi, la Cina ha dichiarato la neutralità climatica per il 2060, l’Europa per il 2050.
Basterà? Quello che sappiamo con certezza è solo che ci sono fenomeni irreversibili, già cominciati. E alcuni di questi riguardano le montagne di tutto il mondo. Dall’Asia all’Alaska, dall’Europa all’Africa i panorami si sono irrimediabilmente modificati, principalmente a causa di 4 fattori: la riduzione dei ghiacciai, lo scioglimento del permafrost, l’eccesso di acqua in quota che causa dissesto idraulico e idrogeologico, e la perdita di biodiversità.
E così sul ghiacciaio dell’Adamello emergono manufatti e resti della prima guerra mondiale, celati dal ghiaccio per oltre un secolo. Anche il ghiacciaio della Marmolada si sta estinguendo velocemente. Vicino a noi ci sono altri esempi rilevanti: Trift, Oberland bernese, Grosslockner, Saas Fee. Nelle Ande, in Asia, in Alaska, in Patagonia sta avvenendo lo stesso. Il ghiacciaio Columbia, in Alberta, Canada, si sta riducendo ad una velocità di circa 5 metri all’anno, è arretrato di oltre 1,5 chilometri ed ha perso oltre la metà del suo volume.
Per chi pratica lo scialpinismo e l’alpinismo invernale su ghiaccio l’accessibilità di certi itinerari sia da un punto di vista tecnico che temporale si è notevolmente ridotta. Così, ad esempio, dobbiamo modificare il tradizionale itinerario di salita verso la vetta del Monte Bianco, per evitare la sempre più frequente caduta di seracchi.
L’innalzamento delle temperature sta causando anche scongelamento del permafrost, il ghiaccio intrappolato nelle rocce delle montagne e nel terreno: quando fonde libera non solo CO2 ma anche metano e materiali organici, contribuendo all’aumento dell’effetto serra 25 volte in più rispetto alla sola CO2. La maggior parte del permafrost è localizzato nelle regioni Artiche ed Antartiche ma è presente anche nelle regioni montuose più elevate delle medie latitudini come le Alpi. Per questo motivo oggi, ad esempio, è più pericoloso salire il Cervino: lo scongelamento del permaforst in roccia porta ad una maggiore frequenza di crolli di piccole e grandi dimensioni, tant’è che il Cervino è stato chiuso al pubblico per evitare incidenti gravi.
Scendendo dai ghiacciai, anche le nostre passeggiate negli ambienti alpini ci fanno attraversare panorami in profonda evoluzione. L’aumento della temperatura sta giocando un ruolo importante nell’innalzamento della linea degli alberi e sta favorendo la colonizzazione in alta quota di specie che “migrano” dalle quote più basse, ormai troppo calde e aride, con una conseguente perdita di copertura vegetale e una progressiva scomparsa delle specie più tipicamente alpino-nivali. Potrebbe sembrare una questione di poco conto. Invece non lo è. Sta avvenendo lo stesso infatti nelle regioni Himalaiane, in particolare nella zona del Monte Everest. Dati satellitari dimostrano un notevole aumento della vegetazione tra i 4150 ed i 6000 metri di quota, con un picco massimo tra i 5000 ed i 5500 metri. Considerata la notevole estensione di queste aree, sempre più scoperte dalla neve e dal ghiaccio, è prevedibile un forte impatto sul ciclo dell’acqua, devastante per l’approvvigionamento idrico di oltre 1,4 miliardi di persone.
Lo sapevamo già? Probabilmente si, con più o meno ricchezza di dettagli, con più o meno esperienza personale, con più o meno consapevolezza. Oggi viviamo la più lunga recessione economica della storia contemporanea, innescata dalla pandemia del Covid-19 ed effetto di un “salto di specie”. Mai prima d’ora però gli esseri umani hanno avuto a disposizione così tanti strumenti tecnologici per superare la crisi e fermare la tempesta perfetta. Oltre alle nuove energie pulite, una di queste armi è l’informazione.
Come istruttori del CAI e amanti della montagna, il nostro dovere si sposa con la nostra passione, perché possiamo contribuire ad una “azione educativa verso i comportamenti più sostenibili”, rendendoli argomento delle nostre lezioni e delle nostre uscite didattiche in ambiente. Anche grazie a questi approfondimenti, che diventeranno argomento didattico all’interno dei nostri corsi di Alpinismo e Scialpinismo, abbiamo l‘opportunità di favorire l’osservazione e mostrare, con gli occhi della scienza, questa nostra natura in trasformazione. Perché l’essere umano non è scosso mai senza l’evidenza della prova.
Possiamo allora tornare alle parole di Hemingway, alla responsabilità condivisa, a cui questa lezione ci ha richiamati e alla quale non possiamo che rispondere se non con il nostro personale impegno. Perché viviamo tutti sullo stesso pianeta.
Alessandra Gambino
Istruttrice Scuola di Sci Alpinismo “Città di Trieste”
foto: triesteallnews.it